Se ne parlerà, lunedì pomeriggio, a Cosenza, presso il salone degli Specchi del palazzo della Provincia, a partire dalle 17 e trenta. In programma, gli interventi di Piero Di Siena, Giuseppe Pierino, Mario Alcaro, Giuseppe Cantarano, Claudio Dionesalvi, Mimmo Rizzuti. Previsti, nel corso del dibattito pubblico, i contributi di Franco Argada e Guido Liguori
Di seguito, il contributo di Mario Alcaro:
Non c’è sinistra senza una proposta che indichi un’alternativa allo stato presente delle cose. Un’alternativa non è un insieme o un coacervo di rivendicazioni: più giusta distribuzione del reddito, miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo eco-compatibile, protezione dell’ambiente e così via. Un’ alternativa manca fin quando non c’è un’idea fondamentale e unificante di tali rivendicazioni e un terreno ben delimitato su cui radicare le varie istanze e le possibili soluzioni per i problemi dell’oggi. Proprio per questo si può dire che una proposta alternativa è latitante nella sinistra italiana. Ma, a dire il vero, dall’aldilà delle Alpi non provengono stimoli e suggerimenti per superare le attuali carenze.
Ritenere che una ricerca, un confronto e un ampio dibattito sul tema nevralgico dell’alternativa di sinistra siano non solo utili e opportuni, ma anche necessari, mi pare scaturisca anche dai più semplici parametri di razionalità. Non c’è alcun dubbio che sino a pochi decenni fa il problema dell’alternativa non si poneva. Esso era stato già risolto. L’alternativa consisteva nel contrapporsi globalmente al sistema capitalistico e nel sostituirlo con un modello di società socialista o comunista. Sennonché, porre ora e nel breve periodo la questione in termini così generali, appare velleitario o comunque poco praticabile. Nasce da qui il bisogno di interrogarsi su ciò rispetto a cui vogliamo essere alternativi. Per questo, occorre ripartire da zero per impegnarsi in un lavoro di ricostruzione di una possibile identità della sinistra. Ed io qui con questo mio scritto, in modo molto incauto, mi azzardo ad avanzare soltanto qualche ipotesi.
L’impegno della sinistra è stato prevalentemente rivolto alla conquista di un maggiore potere contrattuale nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, nella giusta convinzione che la trasformazione dei rapporti di forza nella produzione avrebbe creato nuove opportunità per i ceti subalterni e stimolato una dinamica sociale e politica innovativa e sempre più avanzata. L’azione sindacale e politica nell’ambito produttivo era considerata una condizione indispensabile per determinare un maggior protagonismo dei lavoratori e dei ceti deboli, tanto nell’ambito sociale, quanto in quello politico e istituzionale. La presupposizione teorica di fondo scaturiva dal materialismo storico e dall’individuazione dello sviluppo delle forze produttive come il motore della trasformazione sociale. La crescita della forza produttiva, ossia lo sviluppo economico, era pertanto visto come un fattore positivo, anzi come l’elemento decisivo per l’affermazione di una politica di sinistra nel Paese.
Ora, io dubito che oggi si possa pensare in questi termini. La crescita non comporta più sviluppo sociale e umano. Lo sviluppo economico non stimola più processi virtuosi nei quali si aprono spazi di emancipazione e di benessere per i ceti subalterni. Oggi le cose stanno diversamente. La produzione economica non promuove processi sovrastrutturali che si prestino, mediante un’opportuna azione politica, al conseguimento di maggiori livelli di democrazia e di giustizia sociale.
Nell’attuale fase storica l’economia svolge un ruolo totalizzante. Viviamo nell’epoca dell’economia totale. Economia totale significa che l’economia non gode soltanto di un primato o anche soltanto di un’egemonia su tutto il resto, ma che essa ha acquistato un tale potere dispotico da legittimare l’uso del termine dittatura per designare il suo ruolo nella società. Tutto è subordinato, piegato, finalizzato alle trame del tessuto economico.
Ciò che oggi rende distruttivo il modello sociale capitalistico è l’insaziabile cannibalismo dei parametri economici e aziendalisti, i quali sconfinano dal loro proprio ambito ed invadono tutti gli altri luoghi dell’organizzazione sociale e politica. Essi diventano principi universali ai quali tutto deve essere assoggettato.
La ragione calcolante dell’homo oeconomicus ingurgita, in una sorta di “grande abbuffata”, i vari frutti della civilizzazione occidentale. Individuiamone qualcuno:
1. L’autonomia (relativa) della politica: i politici e le istituzioni statuali sono trasformati in funzionari e apparati al servizio dei grandi potentati economici globali. 2. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico che viene incorporato nei sistemi produttivi. (Si badi che innanzitutto la prima, la ricerca scientifica, e di conseguenza il secondo, lo sviluppo tecnologico, sono beni comuni. Hanno un carattere di per se stesso pubblico, devono di norma adottare criteri e perseguire finalità di interesse generale. E invece persino i geni sono diventati una merce che può essere acquistata al mercato: il mercato dei codici genetici. Come dice Rifkin, la ricerca scientifica è ormai “ostaggio delle multinazionali. I risultati degli studi non sono più patrimonio comune. Tutto è coperto da segreto commerciale”). 3. L’istruzione, la formazione e i sistemi educativi, che, se perdono la loro autonomia – ossia se sono finalizzati al mercato del lavoro e alle sue richieste -, non sono più tali, si snaturano e smarriscono la loro funzione primaria fondamentale. 4. L’ambiente naturale, che diventa sempre più e soltanto riserva naturale, magazzino di materie prime e di energia, terreno di discarica dei rifiuti e dei consumi energetici. 5. Il territorio, che è una sintesi di natura e storia, dal momento che esso risulta dal lungo lavorìo storico che l’uomo esercita sul contesto naturale, e che è sistematicamente distrutto dal grande artefatto umano, dai non luoghi delle megalopoli contemporanee e dai non luoghi degli ipermercati, nei quali si perde ogni contatto con le produzioni locali, i prodotti locali, gli scambi dei beni locali (Alberto Magnaghi). 6. Le comunità, anch’esse sintesi, a livello più alto, di natura e cultura, con le loro relazioni personalizzate, i legami interpersonali, la forza delle appartenenze , l’identificazione con i luoghi e le tradizioni. Esse sono ormai realtà residuali. Le loro diversità vanno scomparendo perché non sono funzionali ai mercati che richiedono omologazione di comportamenti, di abitudini, di gusti, di consumi. 7. Le identità locali, ossia l’ethos, i valori, la cultura di popolazioni che condividono una storia, uno specifico rapporto col territorio, un modo particolare di intendere la funzione civilizzatrice e di dare un senso alla propria esistenza.
In sintesi, oggi il modello economico capitalista ingurgita pezzi decisivi dell’organizzazione sociale e della vita umana, li assimila e li trasforma in ingranaggi del suo meccanismo.E l’ideologia in cui si esprimono senza pudori e reticenze gli insaziabili appetiti proprietari è il liberismo, che è la teorizzazione della riduzione di ogni lato dell’umano vivere e pensare al gigantesco meccanismo della produzione e del mercato globali.
Ebbene, quali effetti produce sul piano politico il contesto socio-economico qui sommariamente abbozzato? Una delle conseguenze più rilevanti è che nella fase attuale dello sviluppo le lotte dei lavoratori perdono il loro valore simbolico di contestazione globale dell’attuale assetto sociale capitalistico. La partita, ormai, si gioca su un terreno che travalica abbondantemente i luoghi di lavoro. E’ l’intera società che è stata aziendalizzata e non si può pretendere che i lavoratori muovano all’attacco ed espugnino tutti i meandri del Palazzo. Così come non si può pretendere che ne minino le fondamenta. Insomma, non si può chiedere alle lotte dei lavoratori più di quanto esse non possano dare. Gli operai e i lavoratori dipendenti sono interessati a lottare contro lo sfruttamento capitalistico del lavoro. E questo è già tanto, anzi è una condizione decisiva per l’avanzamento della società nel suo complesso. Le rivendicazioni dei lavoratori sono un presidio fondamentale per le sorti della democrazia come per i valori di eguaglianza e libertà. Ma è irragionevole pensare che esse debbano superare i luoghi e gli ambiti del processo produttivo. Non si può chiedere ai lavoratori di immolarsi per la “causa” e di inoltrarsi sui territori dove si determinano il rischio ecologico,la mercificazione della esistenza quotidiana, il controllo sociale e via dicendo. Lo possono e lo debbono fare come cittadini alla stessa stregua di tutti gli altri.
Occorre poi rilevare che le istanze di chi lavora, la difesa dell’occupazione e le agitazioni per l’incremento dei salari e dei diritti, per essere praticabili ed efficaci devono essere accompagnati da una istanza di crescita della produzione e di incentivazione dello sviluppo. Sicché esse si muovono, gioco-forza, dentro l’ambito dell’organizzazione capitalistica della produzione economica. Più occupazione, più redditi, più diritti, significa anche più crescita e più sviluppo.
E qui veniamo ad un punto nevralgico di queste note. Lo sviluppo, come s’è detto, non è più progressivo, cioè non agisce più come fattore di emancipazione civile e culturale della popolazione; e non lo è proprio per il dominio incontrastato che le regole aziendalistiche e gli interessi economici capitalistici esercitano sugli altri ambiti della comunità umana. Lo Stato sociale, il Wellfare, ad esempio, non trova una proiezione e un consolidamento con la crescita produttiva. Al contrario, esso è votato ad un totale smantellamento. I ceti sociali deboli non trovano maggiori garanzie ed opportunità di vita, mentre invece si incrementa a dismisura il lavoro precario, la mercificazione di ogni attività umana, l’abbandono delle relazioni sociali. È per questo che le lotte del lavoro non prefigurano di per sé un terreno su cui elaborare uil progetto di un modello sociale alternativo.
Che fare, allora? Io credo che tutto cambia se si assume la questione lavoro in un orizzonte politico definito dal rapporto lavoro-vita? Che significa adottare un criterio di questo tipo? Significa valutare il lavoro nei modi in cui è adoperato o non adoperato nel sistema capitalistico ed evidenziare come esso faccia violenza ed opprima le naturali esigenze e i desideri di una “vita buona” o anche di una vita degna di essere vissuta.
Soffermiamoci un momento su questo tema, apportando qualche esemplificazione. Il lavoro nelle fabbriche, nei luoghi di produzione e distribuzione delle merci, in tutte le attività economiche, assume ritmi, tempi e forme di organizzazione insopportabili e nocive sia sul piano fisico che su quello psichico. È un lavoro stressante e mal retribuito che occupa gran parte della giornata dei lavoratori. Si può dire che il tempo libero quasi scompare e con esso il tempo degli affetti, della convivialità, della cura di se stessi e dei propri interessi culturali, ludici, evasivi. Pensare che il lavoro per come oggi è impiegato, per le modalità in cui si svolge, per la durata della giornata lavorativa, sia appagante e tale da rafforzare il sano equilibrio nell’uso dei dispositivi vitali di cui naturalmente si dispone, è razionalmente impossibile.
Ancora peggiore, ovviamente, è la sorte cui sono destinati i lavoratori senza lavoro, i disoccupati, che anche nei periodi di maggiore sviluppo produttivo, a causa della crescente meccanizzazione, rappresentano una fetta rilevante della totalità della forza-lavoro. Privi di un’occupazione e senza alcun reddito, impossibilitati a svolgere un ruolo socialmente utile, vivono in condizioni mortificanti per la loro dignità e per la loro umanità.
Ma in condizioni tutt’altro che positive trascinano la loro vita anche i precari e gli occupati a tempo determinato. L’incertezza è il dato saliente del loro lavoro e con esso della loro vita. L’impossibilità di progettare il proprio futuro li condanna ad essere soggetti ansiosi, angosciati, smarriti: soggetti la cui esistenza è deturpata dall’incertezza permanente cui sono costretti.
L’adozione di un criterio di valutazione del lavoro in base ai suoi effetti sulle condizioni generali di vita dei lavoratori comporta una serie di conseguenze positive. Qui ne indico soltanto due.
Prima. Il lavoro viene visto nella sua globalità. Sia i lavoratori occupati, sia quelli non occupati o occupati saltuariamente, hanno un interesse convergente a contestare l’assetto capitalista del lavoro. Ed è proprio la conquista di una visione globale della “questione lavoro” e la convergenza sul rifiuto dell’organizzazione del lavoro nell’attuale sistema economico-sociale capitalistico che consente di fare un salto qualitativo nella progettazione di un’alternativa possibile.
Seconda. Le lotte sul lavoro e per il lavoro non assumono un carattere settoriale, ma costituiscono la base che consente di ipotizzare un’organizzazione dell’economia e della società funzionale alle esigenze dei lavoratori in quanto esseri naturali, organismi biologici, enti materiali, prima ancora che soggetti culturali che costruiscono la propria identità nel lungo corso della civilizzazione e della storia.
Qui stiamo parlando del lavoro. Ma il lavoro è solo un esempio, sia pure molto rappresentativo, dell’assunzione sul piano politico di un criterio: quello della valutazione di ogni attività e forma di organizzazione sociale sulla base della loro funzionalità positiva, o al contrario della loro disfunzionalità, ai processi della vita sia biologica che psichica. La cura, ossia la protezione amorevole e l’espansione della vita – della “prima natura” come della “seconda natura” degli umani – deve essere l’idea regolativa, l’elemento normativo, la guida nell’orientamento dell’agire politico e nell’opera di trasformazione dello stato presente delle cose. Prendersi cura del vivente in quanto tale; orientare l’organizzazione sociale, istituzionale e politica verso la conservazione della vita e del mondo; assumere l’umanità come <> (Elena Pulcini); tentare di arrestare la <> che incombe sulla natura, sulla vita e sugli esseri umani: sono questi i compiti della pratica politica e su di essi bisogna costruire un modello di società alternativa.
Ma – è bene prestarvi molta attenzione – il bios, la vita che ci anima (e dunque il mondo, da una parte, e il profilo precipuo dell’essere umano, dall’altra) non è e non deve essere soltanto un fine (lo scopo ultimo della società), ma anche una realtà da cui abbiamo molto da imparare sul piano sociale. Voglio dire, in altri termini, che occorre assumere la vita come epicentro di una ricostruzione sociale e i processi vitali come modelli e criteri per attuare tale ricostruzione.
In che cosa un’organizzazione sociale alternativa deve imitare la vita? Innanzitutto, nelle fondamentali proprietà ontologiche che possiede la vita, e solo la vita. Essa bada principalmente a se stessa, alla sua riproduzione e al suo arricchimento. Come ha acutamente rilevato Hans Jonas, la vita si assume come sito ontologico privilegiato, si costituisce come fine e si organizza teleologicamente in funzione della sua salvaguardia e della sua crescita. Qui siamo di fronte ad una realtà ontologica che può e deve essere assunta come principio etico. La vita come valore prioritario è l’indispensabile presupposto di un’etica della responsabilità. Tutto ciò che degrada, distrugge o depotenzia la vita è male. Dunque, l’uomo, al culmine della scala dei viventi, deve orientare il suo futuro verso un luminoso incremento della vita in tutte le sue manifestazioni.
Ecco una prima formulazione di una visione bio-politica della città degli uomini: i processi che regolano la vita e la sua evoluzione costituiscono modelli cui improntare la condotta degli uomini e l’organizzazione socio-politica della comunità umana.
Ma c’è di più. È molto rilevante nel procedere ad una ricostruzione della città degli uomini cogliere un altro tratto saliente del bios. In esso il tutto prevale sulle parti che lo costituiscono. Ogni singolo elemento trova la sua ragion d’essere e la sua specifica funzione in rapporto all’architettura complessiva della totalità cui inerisce. Non ci viene da questo un grande insegnamento per l’organizzazione complessiva della società? E non è questo un modello da adottare per proporre una società solidale e comunitaria, in cui il bene comune rappresenti la totalità entro la quale inscrivere i ruoli delle parti costitutive e dei singoli individui?
A dire il vero, non è soltanto la vita che realizza una piena funzionalità delle parti al tutto, ma è anche la natura. Essa “aborrisce essere divisa”. Su questo piano occorre prendere atto e rendersi consapevoli che la natura non è ciò che ci hanno raccontato i moderni: pura esteriorità, estensione, meccanismo regolato dal principio di causa-effetto. Essa è physis, ossia ciò che produce quel che viene dal mondo. È la fonte, dunque, d’ogni cosa, e dunque anche della vita con la quale fanno irruzione nel cosmo la soggettività (ogni vivente opera una distinzione fra sé e mondo esterno), la scelta volontaria, l’autonomia, la sensibilità, la memoria, il sentimento e via dicendo. Tra le caratteristiche principali della vita, come s’è detto, c’è la cooperazione virtuosa delle parti che la costituiscono. Ogni soggetto che vive non sarebbe tale se non si realizzasse questa armonica unità. “Come in noi – dice Tommaso Campanella – il braccio non vuole essere diviso dall’omero, né dalla scapola, né la testa dal collo, né le gambe dalle cosce”, così tutti gli organismi scacciano ogni divisione e si costituiscono come totalità fondate sulla cooperazione.
Se si tengono presenti tali processi vitali, ci si accorge che l’idea di una società solidaristica non è campata in aria, non rappresenta soltanto un ideale etico, né tantomeno una aspirazione intellettualistica e utopistica, ma un principio radicato sul tessuto biologico e naturale. Tale idea potrebbe essere intesa come l’effetto di un invito, di una sollecitazione: la società deve essere in grado di realizzare a livelli più alti quei dispositivi che hanno consentito le mirabolanti conquiste del bios.
A questo punto possiamo pervenire a delle conclusioni su ciò che sin qui si è detto. La sinistra, grazie soprattutto al marxismo, ha elaborato i dispositivi analitici per la critica dell’economia politica .Oggi dobbiamo affiancare ad essa una critica biologico-politica, biopolitica si può anche dire, del regime capitalistico, la quale faccia emergere con evidenza le contraddizioni inaccettabili dell’attuale società occidentale anche rispetto alla condizione naturale, vitale e umana della nostra presenza nell’universo-mondo. L’epoca attuale è contrassegnata da rivolgimenti epocali che mettono in crisi non solamente l’organizzazione sociale e politica, ma anche la natura antropologica dell’essere umano. Bisogna elaborare una nuova “grande narrazione” che vada sino in fondo e che spinga lo sguardo sino alle coordinate primordiali della condizione dell’uomo, non solo come essere sociale, ma anche come essere naturale.
Non è vero che si possa legittimamente dire: “C’era una volta la natura, ora non c’è più”. Non si può pensare, cioè, che la natura sia stata esautorata dalla civiltà, dalla cultura, dalla razionalità, con cui invece si intreccia e si coniuga costantemente, Il vivere di oggi arreca danni insopportabili alle condizioni naturali della nostra e dell’altrui vita, che va salvaguardata se si vuole che qualche modello sociale abbia senso. Ciò vuol dire, insomma, che è venuto il momento in cui la politica e l’economia vengano osservate e criticate sulla base di una rinnovata attenzione da rivolgere alle condizioni naturali di quel ente biologico situato nel cosmo che è l’essere umano.
Vita e politica. Modelli di società alternativi
Se ne parlerà, lunedì pomeriggio, a Cosenza, presso il salone degli Specchi del palazzo della Provincia, a partire dalle 17 e trenta. In programma, gli interventi di Piero Di Siena, Giuseppe Pierino, Mario Alcaro, Giuseppe Cantarano, Claudio Dionesalvi, Mimmo Rizzuti. Previsti, nel corso del dibattito pubblico, i contributi di Franco Argada e Guido Liguori
Di seguito, il contributo di Mario Alcaro:
Non c’è sinistra senza una proposta che indichi un’alternativa allo stato presente delle cose. Un’alternativa non è un insieme o un coacervo di rivendicazioni: più giusta distribuzione del reddito, miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo eco-compatibile, protezione dell’ambiente e così via. Un’ alternativa manca fin quando non c’è un’idea fondamentale e unificante di tali rivendicazioni e un terreno ben delimitato su cui radicare le varie istanze e le possibili soluzioni per i problemi dell’oggi. Proprio per questo si può dire che una proposta alternativa è latitante nella sinistra italiana. Ma, a dire il vero, dall’aldilà delle Alpi non provengono stimoli e suggerimenti per superare le attuali carenze.
Ritenere che una ricerca, un confronto e un ampio dibattito sul tema nevralgico dell’alternativa di sinistra siano non solo utili e opportuni, ma anche necessari, mi pare scaturisca anche dai più semplici parametri di razionalità. Non c’è alcun dubbio che sino a pochi decenni fa il problema dell’alternativa non si poneva. Esso era stato già risolto. L’alternativa consisteva nel contrapporsi globalmente al sistema capitalistico e nel sostituirlo con un modello di società socialista o comunista. Sennonché, porre ora e nel breve periodo la questione in termini così generali, appare velleitario o comunque poco praticabile. Nasce da qui il bisogno di interrogarsi su ciò rispetto a cui vogliamo essere alternativi. Per questo, occorre ripartire da zero per impegnarsi in un lavoro di ricostruzione di una possibile identità della sinistra. Ed io qui con questo mio scritto, in modo molto incauto, mi azzardo ad avanzare soltanto qualche ipotesi.
L’impegno della sinistra è stato prevalentemente rivolto alla conquista di un maggiore potere contrattuale nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, nella giusta convinzione che la trasformazione dei rapporti di forza nella produzione avrebbe creato nuove opportunità per i ceti subalterni e stimolato una dinamica sociale e politica innovativa e sempre più avanzata. L’azione sindacale e politica nell’ambito produttivo era considerata una condizione indispensabile per determinare un maggior protagonismo dei lavoratori e dei ceti deboli, tanto nell’ambito sociale, quanto in quello politico e istituzionale. La presupposizione teorica di fondo scaturiva dal materialismo storico e dall’individuazione dello sviluppo delle forze produttive come il motore della trasformazione sociale. La crescita della forza produttiva, ossia lo sviluppo economico, era pertanto visto come un fattore positivo, anzi come l’elemento decisivo per l’affermazione di una politica di sinistra nel Paese.
Ora, io dubito che oggi si possa pensare in questi termini. La crescita non comporta più sviluppo sociale e umano. Lo sviluppo economico non stimola più processi virtuosi nei quali si aprono spazi di emancipazione e di benessere per i ceti subalterni. Oggi le cose stanno diversamente. La produzione economica non promuove processi sovrastrutturali che si prestino, mediante un’opportuna azione politica, al conseguimento di maggiori livelli di democrazia e di giustizia sociale.
Nell’attuale fase storica l’economia svolge un ruolo totalizzante. Viviamo nell’epoca dell’economia totale. Economia totale significa che l’economia non gode soltanto di un primato o anche soltanto di un’egemonia su tutto il resto, ma che essa ha acquistato un tale potere dispotico da legittimare l’uso del termine dittatura per designare il suo ruolo nella società. Tutto è subordinato, piegato, finalizzato alle trame del tessuto economico.
Ciò che oggi rende distruttivo il modello sociale capitalistico è l’insaziabile cannibalismo dei parametri economici e aziendalisti, i quali sconfinano dal loro proprio ambito ed invadono tutti gli altri luoghi dell’organizzazione sociale e politica. Essi diventano principi universali ai quali tutto deve essere assoggettato.
La ragione calcolante dell’homo oeconomicus ingurgita, in una sorta di “grande abbuffata”, i vari frutti della civilizzazione occidentale. Individuiamone qualcuno:
1. L’autonomia (relativa) della politica: i politici e le istituzioni statuali sono trasformati in funzionari e apparati al servizio dei grandi potentati economici globali. 2. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico che viene incorporato nei sistemi produttivi. (Si badi che innanzitutto la prima, la ricerca scientifica, e di conseguenza il secondo, lo sviluppo tecnologico, sono beni comuni. Hanno un carattere di per se stesso pubblico, devono di norma adottare criteri e perseguire finalità di interesse generale. E invece persino i geni sono diventati una merce che può essere acquistata al mercato: il mercato dei codici genetici. Come dice Rifkin, la ricerca scientifica è ormai “ostaggio delle multinazionali. I risultati degli studi non sono più patrimonio comune. Tutto è coperto da segreto commerciale”). 3. L’istruzione, la formazione e i sistemi educativi, che, se perdono la loro autonomia – ossia se sono finalizzati al mercato del lavoro e alle sue richieste -, non sono più tali, si snaturano e smarriscono la loro funzione primaria fondamentale. 4. L’ambiente naturale, che diventa sempre più e soltanto riserva naturale, magazzino di materie prime e di energia, terreno di discarica dei rifiuti e dei consumi energetici. 5. Il territorio, che è una sintesi di natura e storia, dal momento che esso risulta dal lungo lavorìo storico che l’uomo esercita sul contesto naturale, e che è sistematicamente distrutto dal grande artefatto umano, dai non luoghi delle megalopoli contemporanee e dai non luoghi degli ipermercati, nei quali si perde ogni contatto con le produzioni locali, i prodotti locali, gli scambi dei beni locali (Alberto Magnaghi). 6. Le comunità, anch’esse sintesi, a livello più alto, di natura e cultura, con le loro relazioni personalizzate, i legami interpersonali, la forza delle appartenenze , l’identificazione con i luoghi e le tradizioni. Esse sono ormai realtà residuali. Le loro diversità vanno scomparendo perché non sono funzionali ai mercati che richiedono omologazione di comportamenti, di abitudini, di gusti, di consumi. 7. Le identità locali, ossia l’ethos, i valori, la cultura di popolazioni che condividono una storia, uno specifico rapporto col territorio, un modo particolare di intendere la funzione civilizzatrice e di dare un senso alla propria esistenza.
In sintesi, oggi il modello economico capitalista ingurgita pezzi decisivi dell’organizzazione sociale e della vita umana, li assimila e li trasforma in ingranaggi del suo meccanismo.E l’ideologia in cui si esprimono senza pudori e reticenze gli insaziabili appetiti proprietari è il liberismo, che è la teorizzazione della riduzione di ogni lato dell’umano vivere e pensare al gigantesco meccanismo della produzione e del mercato globali.
Ebbene, quali effetti produce sul piano politico il contesto socio-economico qui sommariamente abbozzato? Una delle conseguenze più rilevanti è che nella fase attuale dello sviluppo le lotte dei lavoratori perdono il loro valore simbolico di contestazione globale dell’attuale assetto sociale capitalistico. La partita, ormai, si gioca su un terreno che travalica abbondantemente i luoghi di lavoro. E’ l’intera società che è stata aziendalizzata e non si può pretendere che i lavoratori muovano all’attacco ed espugnino tutti i meandri del Palazzo. Così come non si può pretendere che ne minino le fondamenta. Insomma, non si può chiedere alle lotte dei lavoratori più di quanto esse non possano dare. Gli operai e i lavoratori dipendenti sono interessati a lottare contro lo sfruttamento capitalistico del lavoro. E questo è già tanto, anzi è una condizione decisiva per l’avanzamento della società nel suo complesso. Le rivendicazioni dei lavoratori sono un presidio fondamentale per le sorti della democrazia come per i valori di eguaglianza e libertà. Ma è irragionevole pensare che esse debbano superare i luoghi e gli ambiti del processo produttivo. Non si può chiedere ai lavoratori di immolarsi per la “causa” e di inoltrarsi sui territori dove si determinano il rischio ecologico,la mercificazione della esistenza quotidiana, il controllo sociale e via dicendo. Lo possono e lo debbono fare come cittadini alla stessa stregua di tutti gli altri.
Occorre poi rilevare che le istanze di chi lavora, la difesa dell’occupazione e le agitazioni per l’incremento dei salari e dei diritti, per essere praticabili ed efficaci devono essere accompagnati da una istanza di crescita della produzione e di incentivazione dello sviluppo. Sicché esse si muovono, gioco-forza, dentro l’ambito dell’organizzazione capitalistica della produzione economica. Più occupazione, più redditi, più diritti, significa anche più crescita e più sviluppo.
E qui veniamo ad un punto nevralgico di queste note. Lo sviluppo, come s’è detto, non è più progressivo, cioè non agisce più come fattore di emancipazione civile e culturale della popolazione; e non lo è proprio per il dominio incontrastato che le regole aziendalistiche e gli interessi economici capitalistici esercitano sugli altri ambiti della comunità umana. Lo Stato sociale, il Wellfare, ad esempio, non trova una proiezione e un consolidamento con la crescita produttiva. Al contrario, esso è votato ad un totale smantellamento. I ceti sociali deboli non trovano maggiori garanzie ed opportunità di vita, mentre invece si incrementa a dismisura il lavoro precario, la mercificazione di ogni attività umana, l’abbandono delle relazioni sociali. È per questo che le lotte del lavoro non prefigurano di per sé un terreno su cui elaborare uil progetto di un modello sociale alternativo.
Che fare, allora? Io credo che tutto cambia se si assume la questione lavoro in un orizzonte politico definito dal rapporto lavoro-vita? Che significa adottare un criterio di questo tipo? Significa valutare il lavoro nei modi in cui è adoperato o non adoperato nel sistema capitalistico ed evidenziare come esso faccia violenza ed opprima le naturali esigenze e i desideri di una “vita buona” o anche di una vita degna di essere vissuta.
Soffermiamoci un momento su questo tema, apportando qualche esemplificazione. Il lavoro nelle fabbriche, nei luoghi di produzione e distribuzione delle merci, in tutte le attività economiche, assume ritmi, tempi e forme di organizzazione insopportabili e nocive sia sul piano fisico che su quello psichico. È un lavoro stressante e mal retribuito che occupa gran parte della giornata dei lavoratori. Si può dire che il tempo libero quasi scompare e con esso il tempo degli affetti, della convivialità, della cura di se stessi e dei propri interessi culturali, ludici, evasivi. Pensare che il lavoro per come oggi è impiegato, per le modalità in cui si svolge, per la durata della giornata lavorativa, sia appagante e tale da rafforzare il sano equilibrio nell’uso dei dispositivi vitali di cui naturalmente si dispone, è razionalmente impossibile.
Ancora peggiore, ovviamente, è la sorte cui sono destinati i lavoratori senza lavoro, i disoccupati, che anche nei periodi di maggiore sviluppo produttivo, a causa della crescente meccanizzazione, rappresentano una fetta rilevante della totalità della forza-lavoro. Privi di un’occupazione e senza alcun reddito, impossibilitati a svolgere un ruolo socialmente utile, vivono in condizioni mortificanti per la loro dignità e per la loro umanità.
Ma in condizioni tutt’altro che positive trascinano la loro vita anche i precari e gli occupati a tempo determinato. L’incertezza è il dato saliente del loro lavoro e con esso della loro vita. L’impossibilità di progettare il proprio futuro li condanna ad essere soggetti ansiosi, angosciati, smarriti: soggetti la cui esistenza è deturpata dall’incertezza permanente cui sono costretti.
L’adozione di un criterio di valutazione del lavoro in base ai suoi effetti sulle condizioni generali di vita dei lavoratori comporta una serie di conseguenze positive. Qui ne indico soltanto due.
Prima. Il lavoro viene visto nella sua globalità. Sia i lavoratori occupati, sia quelli non occupati o occupati saltuariamente, hanno un interesse convergente a contestare l’assetto capitalista del lavoro. Ed è proprio la conquista di una visione globale della “questione lavoro” e la convergenza sul rifiuto dell’organizzazione del lavoro nell’attuale sistema economico-sociale capitalistico che consente di fare un salto qualitativo nella progettazione di un’alternativa possibile.
Seconda. Le lotte sul lavoro e per il lavoro non assumono un carattere settoriale, ma costituiscono la base che consente di ipotizzare un’organizzazione dell’economia e della società funzionale alle esigenze dei lavoratori in quanto esseri naturali, organismi biologici, enti materiali, prima ancora che soggetti culturali che costruiscono la propria identità nel lungo corso della civilizzazione e della storia.
Qui stiamo parlando del lavoro. Ma il lavoro è solo un esempio, sia pure molto rappresentativo, dell’assunzione sul piano politico di un criterio: quello della valutazione di ogni attività e forma di organizzazione sociale sulla base della loro funzionalità positiva, o al contrario della loro disfunzionalità, ai processi della vita sia biologica che psichica. La cura, ossia la protezione amorevole e l’espansione della vita – della “prima natura” come della “seconda natura” degli umani – deve essere l’idea regolativa, l’elemento normativo, la guida nell’orientamento dell’agire politico e nell’opera di trasformazione dello stato presente delle cose. Prendersi cura del vivente in quanto tale; orientare l’organizzazione sociale, istituzionale e politica verso la conservazione della vita e del mondo; assumere l’umanità come <> (Elena Pulcini); tentare di arrestare la <> che incombe sulla natura, sulla vita e sugli esseri umani: sono questi i compiti della pratica politica e su di essi bisogna costruire un modello di società alternativa.
Ma – è bene prestarvi molta attenzione – il bios, la vita che ci anima (e dunque il mondo, da una parte, e il profilo precipuo dell’essere umano, dall’altra) non è e non deve essere soltanto un fine (lo scopo ultimo della società), ma anche una realtà da cui abbiamo molto da imparare sul piano sociale. Voglio dire, in altri termini, che occorre assumere la vita come epicentro di una ricostruzione sociale e i processi vitali come modelli e criteri per attuare tale ricostruzione.
In che cosa un’organizzazione sociale alternativa deve imitare la vita? Innanzitutto, nelle fondamentali proprietà ontologiche che possiede la vita, e solo la vita. Essa bada principalmente a se stessa, alla sua riproduzione e al suo arricchimento. Come ha acutamente rilevato Hans Jonas, la vita si assume come sito ontologico privilegiato, si costituisce come fine e si organizza teleologicamente in funzione della sua salvaguardia e della sua crescita. Qui siamo di fronte ad una realtà ontologica che può e deve essere assunta come principio etico. La vita come valore prioritario è l’indispensabile presupposto di un’etica della responsabilità. Tutto ciò che degrada, distrugge o depotenzia la vita è male. Dunque, l’uomo, al culmine della scala dei viventi, deve orientare il suo futuro verso un luminoso incremento della vita in tutte le sue manifestazioni.
Ecco una prima formulazione di una visione bio-politica della città degli uomini: i processi che regolano la vita e la sua evoluzione costituiscono modelli cui improntare la condotta degli uomini e l’organizzazione socio-politica della comunità umana.
Ma c’è di più. È molto rilevante nel procedere ad una ricostruzione della città degli uomini cogliere un altro tratto saliente del bios. In esso il tutto prevale sulle parti che lo costituiscono. Ogni singolo elemento trova la sua ragion d’essere e la sua specifica funzione in rapporto all’architettura complessiva della totalità cui inerisce. Non ci viene da questo un grande insegnamento per l’organizzazione complessiva della società? E non è questo un modello da adottare per proporre una società solidale e comunitaria, in cui il bene comune rappresenti la totalità entro la quale inscrivere i ruoli delle parti costitutive e dei singoli individui?
A dire il vero, non è soltanto la vita che realizza una piena funzionalità delle parti al tutto, ma è anche la natura. Essa “aborrisce essere divisa”. Su questo piano occorre prendere atto e rendersi consapevoli che la natura non è ciò che ci hanno raccontato i moderni: pura esteriorità, estensione, meccanismo regolato dal principio di causa-effetto. Essa è physis, ossia ciò che produce quel che viene dal mondo. È la fonte, dunque, d’ogni cosa, e dunque anche della vita con la quale fanno irruzione nel cosmo la soggettività (ogni vivente opera una distinzione fra sé e mondo esterno), la scelta volontaria, l’autonomia, la sensibilità, la memoria, il sentimento e via dicendo. Tra le caratteristiche principali della vita, come s’è detto, c’è la cooperazione virtuosa delle parti che la costituiscono. Ogni soggetto che vive non sarebbe tale se non si realizzasse questa armonica unità. “Come in noi – dice Tommaso Campanella – il braccio non vuole essere diviso dall’omero, né dalla scapola, né la testa dal collo, né le gambe dalle cosce”, così tutti gli organismi scacciano ogni divisione e si costituiscono come totalità fondate sulla cooperazione.
Se si tengono presenti tali processi vitali, ci si accorge che l’idea di una società solidaristica non è campata in aria, non rappresenta soltanto un ideale etico, né tantomeno una aspirazione intellettualistica e utopistica, ma un principio radicato sul tessuto biologico e naturale. Tale idea potrebbe essere intesa come l’effetto di un invito, di una sollecitazione: la società deve essere in grado di realizzare a livelli più alti quei dispositivi che hanno consentito le mirabolanti conquiste del bios.
A questo punto possiamo pervenire a delle conclusioni su ciò che sin qui si è detto. La sinistra, grazie soprattutto al marxismo, ha elaborato i dispositivi analitici per la critica dell’economia politica .Oggi dobbiamo affiancare ad essa una critica biologico-politica, biopolitica si può anche dire, del regime capitalistico, la quale faccia emergere con evidenza le contraddizioni inaccettabili dell’attuale società occidentale anche rispetto alla condizione naturale, vitale e umana della nostra presenza nell’universo-mondo. L’epoca attuale è contrassegnata da rivolgimenti epocali che mettono in crisi non solamente l’organizzazione sociale e politica, ma anche la natura antropologica dell’essere umano. Bisogna elaborare una nuova “grande narrazione” che vada sino in fondo e che spinga lo sguardo sino alle coordinate primordiali della condizione dell’uomo, non solo come essere sociale, ma anche come essere naturale.
Non è vero che si possa legittimamente dire: “C’era una volta la natura, ora non c’è più”. Non si può pensare, cioè, che la natura sia stata esautorata dalla civiltà, dalla cultura, dalla razionalità, con cui invece si intreccia e si coniuga costantemente, Il vivere di oggi arreca danni insopportabili alle condizioni naturali della nostra e dell’altrui vita, che va salvaguardata se si vuole che qualche modello sociale abbia senso. Ciò vuol dire, insomma, che è venuto il momento in cui la politica e l’economia vengano osservate e criticate sulla base di una rinnovata attenzione da rivolgere alle condizioni naturali di quel ente biologico situato nel cosmo che è l’essere umano.


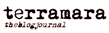

NESSUN COMMENTO