 Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.
Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.
Quella volta trovammo la scuola devastata. Erano entrati di notte. Avevano defecato sulle cattedre, divelto le porte, scaricato gli estintori, allagato i corridoi. L’acqua arrivava ben sopra le caviglie. I collaboratori ATA quasi piangevano dalla rabbia. Sono loro, in questi casi, che devono rimettere tutto a posto. Mi immedesimai. Il preside ci disse che dovevamo rimanere in servizio, rispettare l’orario, nonostante i ragazzi non fossero entrati. Convocò un collegio straordinario da tenersi nel pomeriggio. Mi rimboccai le maniche, infagottai le scarpe, per tutta la mattinata aiutai i collaboratori ATA a liberare i locali dall’acqua. Dopo mezzogiorno uscii e andai in giro per il paese a cercare i ragazzi. Li affrontai a muso duro. Spiegai loro che è da vigliacchi distruggere un edificio scolastico, l’unico vero spazio pubblico disponibile e aperto a tutti.
E che quando commettono simili azioni, a pagarne le conseguenze sono solo i “fessi” come me, che vanno al di là del contratto di lavoro e mettono, in senso reale, le mani nella cacca.
Prima del collegio il preside mi chiese di scrivere un comunicato contro gli atti vandalici. Lo avremmo firmato tutti e spedito ai media. Scrissi poche righe in cui spiegavo che non di semplice vandalismo si era trattato, denunciavo la presenza di una subcultura delinquenziale tra gli adolescenti, accusavo il notabilato e la borghesia locale di esserne complice, sostenevo che a lottare contro questa subcultura noi della scuola e quelli delle parrocchie eravamo rimasti soli. Lessi il comunicato in collegio. La maggior parte dei colleghi approvò. A qualcuno invece venne il “mal di pancia”. Pochi giorni dopo, su un giornaletto locale, nell’individuare le responsabilità morali dei vandalismi, un sedicente opinionista pubblicò un articolo in cui puntava il dito accusatore contro quell’insegnante “operatore dei fatti di Genova (G8) che gioca alla guerriglia culturale anche a scuola”.
Sono stato fortunato. Tanti anni fa il provveditorato mi ha spedito a lavorare in un paese meraviglioso da cui non mi sono più mosso. Dal punto di vista umano e da quello professionale, questo del giornaletto ostile è l’unico spiacevole episodio in cui qualcuno ha brandito la mia storia personale e politica per farmi del male, strumentalizzando il rapporto che ho costruito con i ragazzi. M’è capitato pure di essere fermato e perquisito dai carabinieri in modo plateale, come un criminale, dopo una giornata di lavoro, a poche centinaia di metri dalla scuola. Ma per il resto ho raccolto solo affetto e fiducia.
Gli alunni e le alunne, i loro genitori, i colleghi e le colleghe, presidi e collaboratori, nel porgermi qualche fraterno consiglio affinché non mi mettessi nei guai per le mie idee, mi hanno sempre offerto stima e solidarietà, addirittura protezione quando fui sospeso dal servizio perché arrestato per cospirazione politica e associazione sovversiva. Gli alunni scrissero una lettera aperta in cui mi difendevano e chiedevano la mia immediata liberazione. Fu il collegio dei docenti, all’unanimità, a deliberare il mio immediato reintegro all’indomani della scarcerazione. Al mio ritorno in classe fui accolto da una festa commovente. Il padre di un alunno, consigliere comunale di Alleanza Nazionale, mi strinse la mano: “Al di là delle differenze politiche che ci dividono, sono orgoglioso di avere un insegnante come lei per mio figlio”.
Anche nel territorio in cui lavoro, la gente subisce il bombardamento semiotico che diffonde ansia, paura del diverso, “moral panic”. Però essendo abituata a confrontarsi pure con delinquenti infagottati in abiti borghesi, gran parte della popolazione qui ha sviluppato degli anticorpi. Riconosce le minacce, quando sono concrete. Dopo un primo naturale approccio improntato alla diffidenza, da queste parti i calabresi qualificano i propri interlocutori in base a quel che fanno e a ciò che si portano dentro. Mi sono sempre chiesto: le cose sarebbero andate così se avessi lavorato in un’altra zona d’Italia?
Qualche anno dopo, appena iniziò il procedimento in corte d’Assise, di fronte a una nuova richiesta di sospensione avanzata dalla Digos, il preside si assunse la responsabilità di mantenermi in cattedra. Fu un atto coraggioso e lungimirante, il suo. È realistico affermare che il piacere lo fece a me, ma anche allo Stato. Dopo aver ottenuto tre sentenze di assoluzione piena, qualora fossi stato sospeso, oggi avrei diritto alla restituzione del posto di lavoro e al pagamento di un astronomico risarcimento danni per tutto il tempo perduto.
“Professo’, quest’anno che classe vi hanno dato?”, mi chiede ogni anno la segretaria.
“Ancora la preside non me lo ha detto, signo’. Perché?”
“Perché le mamme vogliono a tutti i costi che i figli vengano con voi. Minacciano di iscriverli da un’altra parte se non li assegniamo alla vostra classe”.
Ogni volta che la signora mi pone il quesito, avverto un tremolio alle gambe e a stento riesco a nascondere la commozione. Per un insegnante non c’è soddisfazione più grande: sapere che i genitori dei tuoi alunni ti danno fiducia e sono felici di affidarti i figli. Dentro di me questo sentimento è rafforzato dai brutti ricordi. Difficile cancellare dalla mente i difficili giorni della perdita del posto di lavoro. Per me si trattò di una doppia ingiustizia. Non ero accusato d’aver commesso reati contro la pubblica amministrazione, a danno di minori, legati alla mafia o allo spaccio di sostanze psicotrope. Soltanto per tali ipotesi di reato la giurisprudenza prevede la sospensione dal servizio in attesa di giudizio. Eppure lo Stato diceva che siccome forse avevo cospirato contro la sua personalità e ostacolato le funzioni di governo, meritavo di essere buttato fuori dalla scuola pubblica.
Ecco perché mi riempie di amarezza, ma non mi sorprende, la vicenda di un collega e compagno docente in un liceo di Senigallia, linciato mediaticamente perché militante dei centri sociali, nonché partecipe di una recente contestazione a Matteo Salvini. Secondo alcune famiglie degli alunni frequentanti quella scuola, il collega addirittura potrebbe plagiare gli studenti. Qualcosa di analogo è accaduto pochi mesi fa, quando Francesco Caruso è stato chiamato a insegnare all’università di Catanzaro. Le corporazioni di polizia sono insorte contro la sua cattedra, provando a scatenare la solita caccia alle streghe. Hanno smesso di urlare “crocifiggi” soltanto quando Francesco è stato accolto dall’applauso caloroso e sincero dei suoi studenti.
Il sistema d’istruzione italiano non è immune dall’ondata di odio sociale che sta attraversando il Paese. Il tutto è reso più difficile dal radicale cambiamento della forma mentis di gran parte della classe docente. Fino alla metà degli anni ottanta, tra i banchi di scuola abbiamo incontrato docenti liberali, fascisti, comunisti, cattolici, socialisti. Discutibili le posizioni di ognuno, ma ciascuno aveva una storia da raccontare ai ragazzi. Nei due decenni successivi, si è diffusa la figura dell’insegnante zero: solo svolgimento dei programmi, progetti, burocrazia, estraneità alla vita pubblica e nessun impegno nel sociale. Non è questa la condizione di tutta la classe docente, però gran parte incarna tale ruolo, per effetto dei mutamenti avvenuti nella società.
Allora, tra ossessione securitaria e ignavia dilagante, è ovvio che qualsiasi personalità riconoscibile rappresenti una minaccia. Le recenti ondate di panico sulla questione dell’emendamento alla riforma della scuola, che sarebbe stato ispirato alla presunta teoria del gender, testimoniano il clima psicotico che serpeggia intorno agli edifici scolastici. Eppure sono certo che a proteggere il collega di Senigallia, e con lui la libertà d’insegnamento che oggi subisce attacchi gravissimi, saranno sia la sua professionalità sia la sensibilità dei ragazzi. Che quando ne conosceranno preparazione e capacità didattiche, metteranno a tacere le allarmistiche sirene della nuova inquisizione.
“L’educazione è sempre un atto politico”, ribadisce spesso Francesco Bossio, docente universitario di Pedagogia, cattolico, studioso dotato di grande equilibrio. Bossio sostiene che nell’insegnamento, centrale è la relazione che si istituisce tra docente e allievo.
“Ciò che arriva al ragazzo – spiega – è ciò che io sono”. Se un professore crede in un ideale, i suoi alunni crederanno in qualcosa. Se un professore non crede in nulla, quel nulla arriverà ai suoi allievi. È ovvio che non bisogna plagiarli, ma non è possibile che un educatore si spersonalizzi al punto da annullare se stesso. I maestri buoni insegnano in paradiso. I cattivi maestri insegnano ai figli della terra.
*Claudio Dionesalvi è attivista, giornalista e scrittore. Il suo blog si trova all’indirizzo www.inviatodanessuno.it, contiene l’archivio dei suoi lavori e altre riflessioni sulla scuola.
“Professò, mio figlio deve stare con voi”
 Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.
Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.
Quella volta trovammo la scuola devastata. Erano entrati di notte. Avevano defecato sulle cattedre, divelto le porte, scaricato gli estintori, allagato i corridoi. L’acqua arrivava ben sopra le caviglie. I collaboratori ATA quasi piangevano dalla rabbia. Sono loro, in questi casi, che devono rimettere tutto a posto. Mi immedesimai. Il preside ci disse che dovevamo rimanere in servizio, rispettare l’orario, nonostante i ragazzi non fossero entrati. Convocò un collegio straordinario da tenersi nel pomeriggio. Mi rimboccai le maniche, infagottai le scarpe, per tutta la mattinata aiutai i collaboratori ATA a liberare i locali dall’acqua. Dopo mezzogiorno uscii e andai in giro per il paese a cercare i ragazzi. Li affrontai a muso duro. Spiegai loro che è da vigliacchi distruggere un edificio scolastico, l’unico vero spazio pubblico disponibile e aperto a tutti.
E che quando commettono simili azioni, a pagarne le conseguenze sono solo i “fessi” come me, che vanno al di là del contratto di lavoro e mettono, in senso reale, le mani nella cacca.
Prima del collegio il preside mi chiese di scrivere un comunicato contro gli atti vandalici. Lo avremmo firmato tutti e spedito ai media. Scrissi poche righe in cui spiegavo che non di semplice vandalismo si era trattato, denunciavo la presenza di una subcultura delinquenziale tra gli adolescenti, accusavo il notabilato e la borghesia locale di esserne complice, sostenevo che a lottare contro questa subcultura noi della scuola e quelli delle parrocchie eravamo rimasti soli. Lessi il comunicato in collegio. La maggior parte dei colleghi approvò. A qualcuno invece venne il “mal di pancia”. Pochi giorni dopo, su un giornaletto locale, nell’individuare le responsabilità morali dei vandalismi, un sedicente opinionista pubblicò un articolo in cui puntava il dito accusatore contro quell’insegnante “operatore dei fatti di Genova (G8) che gioca alla guerriglia culturale anche a scuola”.
Sono stato fortunato. Tanti anni fa il provveditorato mi ha spedito a lavorare in un paese meraviglioso da cui non mi sono più mosso. Dal punto di vista umano e da quello professionale, questo del giornaletto ostile è l’unico spiacevole episodio in cui qualcuno ha brandito la mia storia personale e politica per farmi del male, strumentalizzando il rapporto che ho costruito con i ragazzi. M’è capitato pure di essere fermato e perquisito dai carabinieri in modo plateale, come un criminale, dopo una giornata di lavoro, a poche centinaia di metri dalla scuola. Ma per il resto ho raccolto solo affetto e fiducia.
Gli alunni e le alunne, i loro genitori, i colleghi e le colleghe, presidi e collaboratori, nel porgermi qualche fraterno consiglio affinché non mi mettessi nei guai per le mie idee, mi hanno sempre offerto stima e solidarietà, addirittura protezione quando fui sospeso dal servizio perché arrestato per cospirazione politica e associazione sovversiva. Gli alunni scrissero una lettera aperta in cui mi difendevano e chiedevano la mia immediata liberazione. Fu il collegio dei docenti, all’unanimità, a deliberare il mio immediato reintegro all’indomani della scarcerazione. Al mio ritorno in classe fui accolto da una festa commovente. Il padre di un alunno, consigliere comunale di Alleanza Nazionale, mi strinse la mano: “Al di là delle differenze politiche che ci dividono, sono orgoglioso di avere un insegnante come lei per mio figlio”.
Anche nel territorio in cui lavoro, la gente subisce il bombardamento semiotico che diffonde ansia, paura del diverso, “moral panic”. Però essendo abituata a confrontarsi pure con delinquenti infagottati in abiti borghesi, gran parte della popolazione qui ha sviluppato degli anticorpi. Riconosce le minacce, quando sono concrete. Dopo un primo naturale approccio improntato alla diffidenza, da queste parti i calabresi qualificano i propri interlocutori in base a quel che fanno e a ciò che si portano dentro. Mi sono sempre chiesto: le cose sarebbero andate così se avessi lavorato in un’altra zona d’Italia?
Qualche anno dopo, appena iniziò il procedimento in corte d’Assise, di fronte a una nuova richiesta di sospensione avanzata dalla Digos, il preside si assunse la responsabilità di mantenermi in cattedra. Fu un atto coraggioso e lungimirante, il suo. È realistico affermare che il piacere lo fece a me, ma anche allo Stato. Dopo aver ottenuto tre sentenze di assoluzione piena, qualora fossi stato sospeso, oggi avrei diritto alla restituzione del posto di lavoro e al pagamento di un astronomico risarcimento danni per tutto il tempo perduto.
“Professo’, quest’anno che classe vi hanno dato?”, mi chiede ogni anno la segretaria.
“Ancora la preside non me lo ha detto, signo’. Perché?”
“Perché le mamme vogliono a tutti i costi che i figli vengano con voi. Minacciano di iscriverli da un’altra parte se non li assegniamo alla vostra classe”.
Ogni volta che la signora mi pone il quesito, avverto un tremolio alle gambe e a stento riesco a nascondere la commozione. Per un insegnante non c’è soddisfazione più grande: sapere che i genitori dei tuoi alunni ti danno fiducia e sono felici di affidarti i figli. Dentro di me questo sentimento è rafforzato dai brutti ricordi. Difficile cancellare dalla mente i difficili giorni della perdita del posto di lavoro. Per me si trattò di una doppia ingiustizia. Non ero accusato d’aver commesso reati contro la pubblica amministrazione, a danno di minori, legati alla mafia o allo spaccio di sostanze psicotrope. Soltanto per tali ipotesi di reato la giurisprudenza prevede la sospensione dal servizio in attesa di giudizio. Eppure lo Stato diceva che siccome forse avevo cospirato contro la sua personalità e ostacolato le funzioni di governo, meritavo di essere buttato fuori dalla scuola pubblica.
Ecco perché mi riempie di amarezza, ma non mi sorprende, la vicenda di un collega e compagno docente in un liceo di Senigallia, linciato mediaticamente perché militante dei centri sociali, nonché partecipe di una recente contestazione a Matteo Salvini. Secondo alcune famiglie degli alunni frequentanti quella scuola, il collega addirittura potrebbe plagiare gli studenti. Qualcosa di analogo è accaduto pochi mesi fa, quando Francesco Caruso è stato chiamato a insegnare all’università di Catanzaro. Le corporazioni di polizia sono insorte contro la sua cattedra, provando a scatenare la solita caccia alle streghe. Hanno smesso di urlare “crocifiggi” soltanto quando Francesco è stato accolto dall’applauso caloroso e sincero dei suoi studenti.
Il sistema d’istruzione italiano non è immune dall’ondata di odio sociale che sta attraversando il Paese. Il tutto è reso più difficile dal radicale cambiamento della forma mentis di gran parte della classe docente. Fino alla metà degli anni ottanta, tra i banchi di scuola abbiamo incontrato docenti liberali, fascisti, comunisti, cattolici, socialisti. Discutibili le posizioni di ognuno, ma ciascuno aveva una storia da raccontare ai ragazzi. Nei due decenni successivi, si è diffusa la figura dell’insegnante zero: solo svolgimento dei programmi, progetti, burocrazia, estraneità alla vita pubblica e nessun impegno nel sociale. Non è questa la condizione di tutta la classe docente, però gran parte incarna tale ruolo, per effetto dei mutamenti avvenuti nella società.
Allora, tra ossessione securitaria e ignavia dilagante, è ovvio che qualsiasi personalità riconoscibile rappresenti una minaccia. Le recenti ondate di panico sulla questione dell’emendamento alla riforma della scuola, che sarebbe stato ispirato alla presunta teoria del gender, testimoniano il clima psicotico che serpeggia intorno agli edifici scolastici. Eppure sono certo che a proteggere il collega di Senigallia, e con lui la libertà d’insegnamento che oggi subisce attacchi gravissimi, saranno sia la sua professionalità sia la sensibilità dei ragazzi. Che quando ne conosceranno preparazione e capacità didattiche, metteranno a tacere le allarmistiche sirene della nuova inquisizione.
“L’educazione è sempre un atto politico”, ribadisce spesso Francesco Bossio, docente universitario di Pedagogia, cattolico, studioso dotato di grande equilibrio. Bossio sostiene che nell’insegnamento, centrale è la relazione che si istituisce tra docente e allievo.
“Ciò che arriva al ragazzo – spiega – è ciò che io sono”. Se un professore crede in un ideale, i suoi alunni crederanno in qualcosa. Se un professore non crede in nulla, quel nulla arriverà ai suoi allievi. È ovvio che non bisogna plagiarli, ma non è possibile che un educatore si spersonalizzi al punto da annullare se stesso. I maestri buoni insegnano in paradiso. I cattivi maestri insegnano ai figli della terra.
*Claudio Dionesalvi è attivista, giornalista e scrittore. Il suo blog si trova all’indirizzo www.inviatodanessuno.it, contiene l’archivio dei suoi lavori e altre riflessioni sulla scuola.
 Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.
Come antidoto al clima d’odio e all’attacco al libero pensiero che alcuni vorrebbero fomentare.


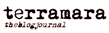

NESSUN COMMENTO